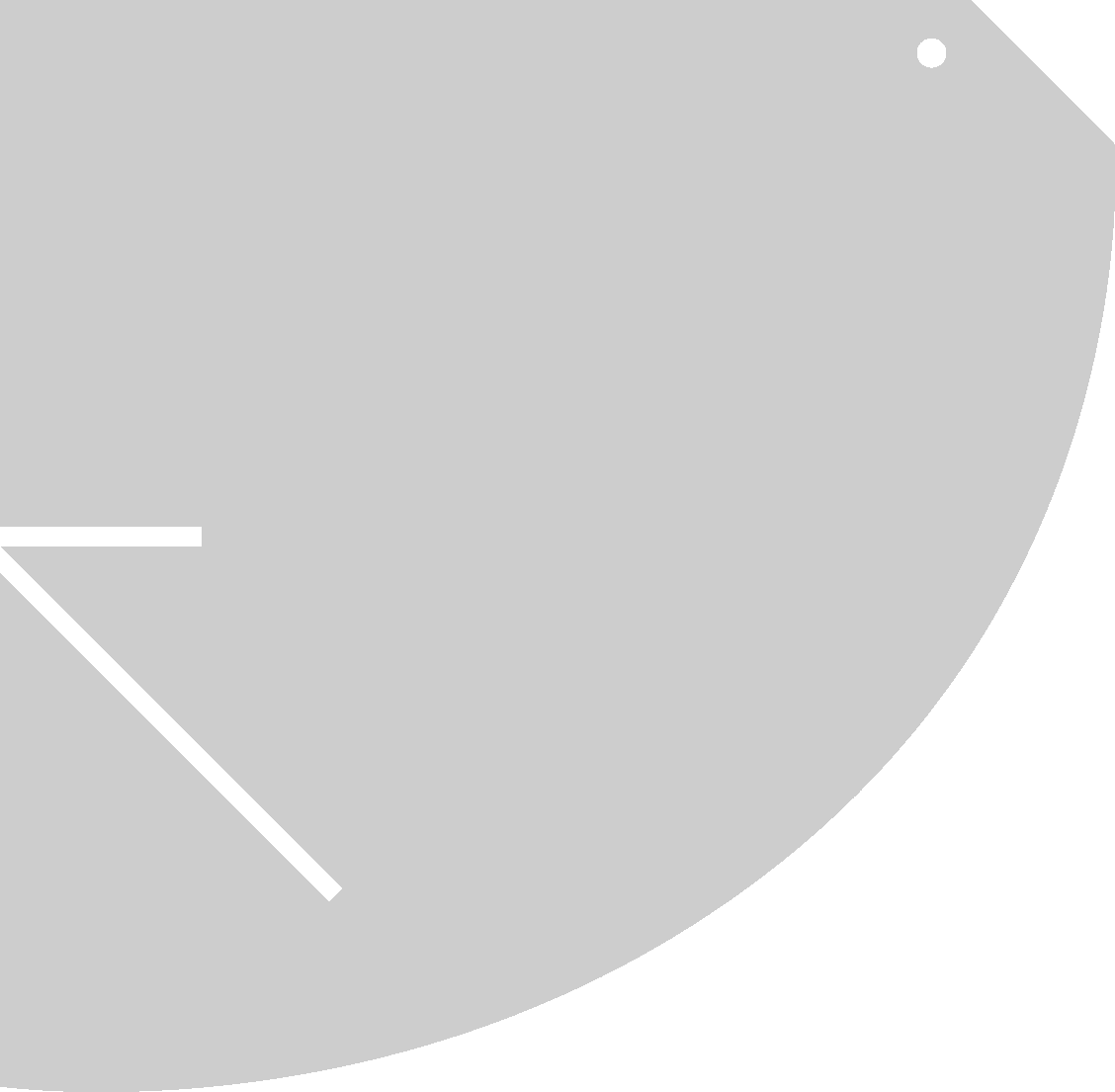BIANCO
24 Marzo 2021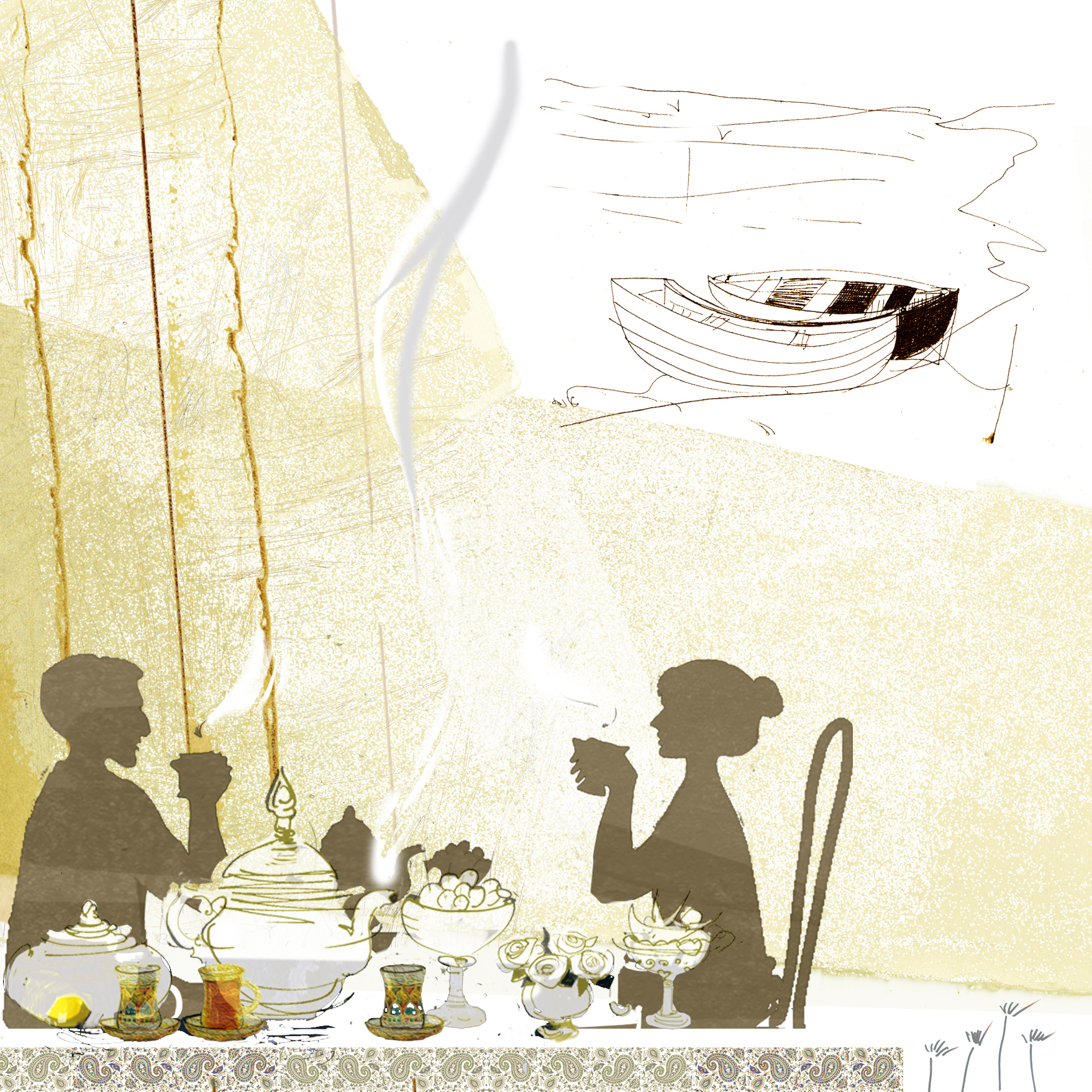
COCOMERO CITY
25 Marzo 2021Bottone è un libro illustrato. Nasce di getto, è una necessita. Raccoglie le immagini e ricordi d’infanzia. Il libro è stato pubblicato in azero e georgiano nel 2014. Nella collana RAGNO MAGICO dedicata all’infanzia la casa editrice ARACNE lo pubblica in Italia nel 2015 .
Data:
2012-2013
Autori:
Radmila Gordic, Nino Peradze
Fin dall’inizio mi era piaciuto il soprannome “Bottone” che mi aveva dato Papà. Di tutti i bambini, dicono che ero la più piccola e la più vivace. Mamma diceva a Papà che non era il caso di chiamarmi “Bottone”, che era un brutto soprannome per una bambina. Papà rideva e diceva: “Ma per me Bottone è la figlia che ho sempre sognato”. E mi lanciava in alto. E rideva quando io ridevo. Mi portava sulle spalle e ripeteva: “Bottone, Bottone, Bottoncino mio”.
Pavle, mio fratello maggiore, da sempre serio e moderato in tutto, mi colpiva la testa con le dita dicendo che mi stava meglio il soprannome “Pallina salterina”. Non mi piaceva quando mi colpiva con le dita perché poi, a lungo andare, mi doleva la testa. E ancora oggi quando ho mal di testa penso che sia a causa di tutti quei colpi e delle botte che mi sono presa da piccola. Anche se lo faceva solo quando Papà non lo vedeva. Ma io gli volevo bene e non mi sognavo di fare la spia. Forse perché a volte pensavo che avesse anche ragione, perché il mio amico Šilo e io eravamo sempre da qualche parte a saltare.
Nonna, che tutti chiamavano Mamma o, abbreviato, Maja, andava per il cortile con il mazzo di chiavi appese alla gonna di panno che non toglieva né in estate né in inverno. Era severa, ed era una donna alta e ossuta. Si alzava prima di tutti e perlustrava i vari edifici del podere. E quando si accorgeva che io e Šilo eravamo nascosti intorno alla distilleria o seduti sull’albero, faceva un gesto con la mano come a dire “ma va’ là” e borbottava: “Ne sapete una più del diavolo”.
Quando restavamo a casa da soli con Nonno Risto, salivamo sui pagliai dall’altra parte della strada e del podere. Da là si vedevano Potok, la foresta di querce, Stena e Osoje. Ci sembrava che il fieno pian piano si sollevasse e che presto io e Šilo saremmo partiti per un viaggio intorno al mondo. Così fantasticavamo, mentre Nonno Risto girava intorno al recinto con le biche di fieno disposte tutte in cerchio, e ci raccomandava di emettere il nostro giudizio. Noi saltavamo e dicevamo: “Prima apri la credenza e dacci un dolcetto per ciascuno!” Lui aspettava paziente che scendessimo, perché era buono come il pane.
Io e Šilo ridevamo e minacciavamo di saltar giù se non ci portava subito il piatto con i cornetti che Maja aveva sfornato di mattina. Allora Nonno Risto si prendeva la testa tra le mani, spariva dall’aia e poi tornava con qualche altra leccornia per me e per il mio amico Šilo. Perché chi mai poteva aprire la credenza?! Nessuno. Neanche Nonno. Neanche mio Papà Mitar. Soltanto Maja. Lei la chiudeva bene a chiave dopo aver dato a ciascun componente della famiglia un cornetto. Spesso accadeva che i cornetti alla fine ammuffissero. Allora lei li prendeva e, di nascosto, le dava alla scrofa che d’estate sonnecchiava sempre sotto il grande visciolo, nel frutteto più in alto. Io e Šilo sapevamo ogni cosa.
Quando tutti erano impegnati in qualche faccenda, entravamo nella grande stanza della casa, ci avvicinavamo alla vetrina e, con il rasoio di Papà, tagliavamo il cellofan sulle confezioni nuove dei cioccolatini di Maja. Potevamo aspettare anche alcuni giorni prima di deciderci a tirar fuori dalla scatola il primo cioccolatino. Šilo in questo era un mago: non so come facesse, ma riusciva a sollevare il coperchio della scatola e a sfilare il cartoncino e poi, altrettanto abilmente, a rimettere tutto a posto. I cioccolatini li mettevamo in tasca, di nascosto uscivamo dalla grande stanza, ci arrampicavamo sul gelso e mangiavamo. Soltanto verso Natale saltò fuori l’intero scandalo. Tutti stavano seduti in silenzio attorno alla tavola mentre Maja sbuffava ed esigeva che le venisse detto chi e quando aveva rubato i cioccolatini e inoltre chi aveva osato prendersi gioco di lei?!
Qualcuno era morto in paese e Maja e Risto erano andati al funerale. Giunto il momento in cui, secondo le usanze, bisognava offrire qualcosa ai convenuti presso la tomba del defunto, Maja aveva aperto la confezione di cioccolatini, sollevando il cartoncino. E cosa aveva visto? La scatola era vuota. Pavle mi trascinò dietro il caseificio e mi colpì dolorosamente cinque volte sulla testa, nel suo solito modo, con le dita. “Confessa! So che sei stata tu con quel diavolo di Šilo ad aprire la scatola dei cioccolatini!” Io lo guardavo e stavo zitta.
Mamma Raja veniva da un altro pianeta. Di lei si fidavano sia le persone che gli animali. Pregava sempre davanti all’icona del santo e quando un giorno le domandai: “Mamma, chi è questo Dio che nomini in continuazione?” mi guardò seria negli occhi e con il dito fece segno di starmene zitta. Poi mi portò nella stalla e disse: “Guarda sul pagliericcio, dietro di me”. Io e Šilo ci girammo e scorgemmo gli occhi guardinghi della gatta che aveva appena fatto i cuccioli e nascondeva i gattini nel nuovo nido. Quando Mamma disse a me e a Šilo: “Ogni essere vivente ha un’anima”, capii che anche la gatta aveva inteso le sue parole e che per questo si fidava di lei.
Non so quanto Mamma Raja fosse davvero di animo buono e quanto invece desiderasse compiacere tutti, per non dire, piacere a tutti. Con tenace ostinazione sopportava sia il carico di lavoro nelle faccende domestiche dei Tosović, sia i loro caratteri.
Le prime immagini che ricordo profumano di granaio e di montagne di pannocchie di granoturco. Il granaio era così pieno che Nonno Risto lasciava la porta aperta e faceva la guardia alle pannocchie fino a quando non iniziava la sgranatura. La gente si radunava, saliva sulla montagna di granoturco, scivolava, saliva di nuovo. Si sfogliavano e si sgranavano le pannocchie fino a tarda notte, ridendo e scherzando.
E quando Nonno Risto spostava il berretto sulla nuca, Mamma Raja si alzava e, in silenzio, lasciava il granaio. Subito dopo tornava, con un vassoio pieno di bicchieri di grappa bollente.
Tutti i Tosović amavano la šljivovica (grappa di prugne), tutti la bevevano volentieri sia calda che fredda. Vicino all’alambicco, nella gioia e nel dolore. In seguito Mamma mi confessò che aveva due teiere per la grappa calda: in quella sbreccata faceva bollire il peperone rosso con l’acqua, nell’altra la vera grappa di prugne. Non so da dove le venisse tutta quella forza: dopo la serata e il lavoro della sgranatura, la mattina si alzava, leggera come una piuma, e con la brocca d’acqua e l’asciugamano pulito aspettava Maja davanti al casolare. Maja si lavava il viso e silenziosamente si avvicinava al piccolo ricovero sotto il gelso, dove ad aspettarla c’erano il caffè e la grappa. Mentre sul filo gocciolavano le garze appena lavate, Mamma Raja sfregava con la spazzola il pavimento e le panche del caseificio. Le zie ancora assonnate mungevano le mucche, scaldavano il latte e lo versavano ancora bollente nei mastelli di legno. Come un guardiano, con il mazzo di chiavi attaccato alla cintola, Maja si aggirava tra i latticini. Si fermava chinandosi su ogni tinozza. E poi, soddisfatta, si avvicinava a Mamma Raja che toglieva il kajmak e lo metteva in un mastello di legno più alto, e aggiungeva: “Tu hai bevuto la rakija dell’altra teiera, quella sbreccata”. Mamma Raja salava la panna appena fatta facendo finta di non sentire.
Nessuno sapeva tendere la garza bene come Maja. Io e Šilo seguivamo le mosche che dal buco della serratura volavano dentro il caseificio e si lanciavano in picchiata sui mastelli del formaggio. Rimbalzavano come palline e di nuovo cadevano sulla garza ben tesa. Così giacevano finché qualcuno non le raccoglieva e non le buttava fuori, morte.
Già da bambina ero in grado di riconoscere da lontano i pagliai di Maja. Il fieno lo raccoglieva con i figli maschi. Nell’aia all’interno del recinto, abbigliata con la sua gonna di panno scuro, stava in piedi vicino al palo, dritta e fiera come una statua. Con un grande rastrello raccoglieva i mucchietti di fieno e, calpestandoli ben bene, li sistemava intorno al palo. Così era la nostra Maja.
Nelle sere invernali Mamma Raja e Maja rammendavano i pantaloni, le calze, i guanti e i cappotti. Non eravamo poveri. Ma a Maja piaceva risparmiare. Non ho mai capito se lo facesse perché era tirchia o perché le piaceva “essere pregata”. Papà spesso si accigliava, persino quando Mamma di sera gli versava l’acqua per il bagno. Mentre si lavava e insaponava, sibilava rabbioso: “Non siamo così miseri da dover appendere al chiodo la borsa del pane. Mi vergogno quando viene qualcuno. Ho moglie e figli, ma devo aspettare che sia mia madre a darmi un tozzo di pane. Sogno per i miei figli e te una vita migliore”. Mamma diceva a bassa voce: “Stai zitto, Mitar, è tua madre. Zitto che i bambini non ti sentano” - diceva, poi si sedeva sulla seggiolina e in silenzio continuava a rammendare. Io sollevavo la pesante coperta che mi soffocava e osservavo dal letto Mamma che si soffermava a lungo a scegliere i bottoni nella scatola di legno e poi li cuciva sul mio maglione invernale.
Penso che Maja fosse comunque buona. Altrimenti mio padre non le avrebbe voluto bene. Il cancello che dava sulla strada non era mai chiuso. Nel ricovero, sotto il gelso su cui io e Šilo ci arrampicavamo, c’era la borraccia con la grappa, l’acqua del pozzo e sempre qualcosa da mangiare. I viandanti che passavano lì per caso lo sapevano. E nelle calde giornate, così sudati, entravano nel cortile deserto per ristorarsi e riposarsi un po’. Io e Šilo, seduti tra le fronde, osservavamo quel mondo sconosciuto degli adulti, pieno di regole e segni che noi bambini interpretavamo in un modo tutto nostro.
Oggi mi rendo conto che Maja aveva paura della morte. Picchiava forte Nonno Risto ogni volta che lui gliela ricordava. Nonno Risto aveva venduto dei campi a Potok per comprare la bara e il terreno dove mettere la tomba. Quando tutti, dopo una dura giornata di lavoro in campagna, dormivano al fresco nella grande stanza al primo piano, nonno Risto e Maja litigavano in cantina. Nonna entrava e colpiva come poteva le galline che covavano, accudivano i pulcini o facevano le uova nella cassa da morto. Trascinava la cassa aperta verso l’uscita “che tutti vedano come hai speso i soldi dei fertili campi di Potok”. Risto dapprima aspettava che le passasse la rabbia, poi si fermava sulla porta e lasciava che lei lo picchiasse. “Crepa! Maledetto il tuo seme! Con che razza di idiota sono andata a fare dei figli!?” Io e Šilo, attraverso l’inferriata e il vetro rotto, guardavamo loro due che non la finivano di bisticciare per la cassa da morto e le galline che starnazzavano volando da una parte all’altra della cantina. E quando infine tutto tornava calmo e tranquillo, e quando anche Nonno e Nonna si addormentavano nella stanzetta, sotto l’icona di San Nicola e la foto delle nozze, scendevamo in cantina e prendevamo le uova deposte. Ci arrampicavamo sul fienile e, sul fieno, facevamo frittate e omelette mescolando terra e uova.
Così passava l’estate: si estirpavano le erbacce e si zappavano gli orti, si tagliava la legna, si mieteva il grano. Io e Šilo ci trasferivamo dal gelso al grande visciolo nel giardino di sopra. E mentre tutti aspettavano la trebbiatura del grano, noi due dall’alto guardavamo la scrofa che ingrassava.
Al chiaro di luna, con l’erba tagliata di fresco, l’aia risplendeva come una moneta. Quando Nonno Risto arrivò con il primo rimorchio con il grano, noi, bambini e donne ci ritirammo dall’altra parte della strada e, all’ombra del gelso, in silenzio assistevamo allo spettacolo. Mio Papà entrò per primo nella stalla seguito da tutti gli altri contadini. Lo zio Lazar scaricava in silenzio le spighe dorate dal rimorchio, i nostri vicini le prendevano con la forca e le sistemavano intorno al recinto, a raggiera. Alto come un pioppo e nudo fino alla cintola, Papà uscì dalla stalla con il suo cavallo nero. Si avvicinò al carro e in silenzio si fece dare la corda da Nonno. Contati tra sé e sé i passi dall’aia al cancello, si girò e lanciò la corda. Il cavallo per un attimo si piantò, alzò lo zoccolo, fece un passo indietro. E poi si concentrò aspettando il prossimo comando. Papà urlò e il cavallo si mosse correndo verso il recinto, dietro di lui gli altri cavalli. La corsa crebbe in un galoppo, i chicchi si sgranavano sotto gli zoccoli, scomparivano sotto le spighe secche. Si alzò la polvere, con il tempo divenne appiccicosa, densa, palpabile. Al suo interno sparirono il recinto, il fieno, i contadini a torso nudo, i busti dei cavalli, mio Papà. Si sentivano lo scalpitio, le urla, i fischi.
Non so se Mamma Raja volesse bene a Maja. So però che la rispettava. E Maja rispettava lei, almeno credo. Ma si arrabbiò a morte quando Mamma sostenne Papà nella decisione di trasferirci in città.
Papà divenne membro del partito comunista e operaio alla 'Gommaria', così chiamavamo la nostra fabbrica di prodotti di gomma. Maja disse che non gli avrebbe mai perdonato il fatto di voler lasciare i suoi beni in campagna e l’aria pulita in cambio di una vita miserabile, fuliggine e puzza di gomma. Mentre Maja parlava, Mamma setacciava la farina su una ciotola di legno, io catturavo gli sguardi di mio padre sul suo vestito estivo, mentre Nonno con un gesto della testa indicava a Pavle la credenza. Mio fratello si alzò e portò la borraccia con la grappa. La versò nel bicchiere di Papà, di Lazar e di Nonno Risto. Mamma rigirò la sfoglia di grano saraceno sulla piastra incandescente della stufa, Nonno bevve tutto d’un sorso la grappa di prugne, si voltò verso di lei e disse: “Per il momento vi darò una casetta di legno, così avrete dove dormire”. E uscì fuori.
Il giorno seguente, quando Papà e zio Lazar portarono in città la nostra nuova casa di legno, Šilo trovò sotto il gelso un pulcino tramortito. Pensammo che fosse nato sull’albero e che, chissà per quale motivo, di notte fosse caduto dal nido. Pavle si mise a ridere dicendo che eravamo stupidi, che alle gallinelle nane piace salire e dormire sugli alberi, ma che le loro uova, come quelle delle altre galline, si schiudono nel pollaio. Quando il pulcino si riprese, corse dietro a sua madre.
Certamente, essendo così piccolo, con il caldo e nel lungo tratto di strada dal pollaio al gelso, si era preso un’insolazione ed era svenuto.
Io e Šilo demmo un’occhiata a Nonno Risto che dal mattino si faceva aria con il cappello di paglia sulla panca davanti al casolare e come in trance ripeteva: “Boia come scotta. La terra brucia”. E a quel punto non sapevamo più cosa pensare.
Quello stesso mattino Maja ordinò che si iniziasse con le grandi pulizie della casa. Le sorelle di Papà lavarono le finestre, portarono fuori i materassi e pulirono i pavimenti in legno. Io e Šilo dal gelso guardavamo Mamma che da sola sfregava gli asciugamani nel trogolo, vicino alla distilleria. Per primo venne ad aiutarla Pavle per portare il pesante pentolone d’acqua bollente fino alla vasca e alla fontana. Maja scese alla pozza d’acqua sorgiva giusto quando toccava alle lenzuola della stanza grande. Lei strofinava da una parte e Mamma dall’altra. Poi Maja, senza dire una parola, salì in groppa al morello di Papà e sparì dietro l’aia.
Mamma lavava e vomitava per il nervoso finché l’ultimo lenzuolo non fu lavato. Pavle l’aiutò a strizzare bene il tutto e a portarlo nel cortile. Quando il bucato fu steso e il cortile profumava di sapone, Mamma andò a riposarsi un po’. Le galline di Pavle, Bianca e Rossa, passeggiavano per i bianchi viali con il bucato appena steso e prendevano il fresco. Io e Šilo invece sguazzavamo ancora per un bel po’ nell’acqua della sorgente con le ultime bolle di sapone. Tutti aspettavano il giorno di San Ilija mentre io aspettavo che mio Papà tornasse dalla 'Gommaria'.
Il nostro Pulcino di gallina nana cresceva e veniva dietro a me e a Šilo. Papà tardava e tutti in casa tacevano in modo strano. Sentii Mamma dire a Pavle che Papà stava di sicuro cercando in città un posto dove mettere la nostra casa di legno. Maja, che mescolava l’impasto per la torta, disse: “Forse si sta godendo il denaro della prima paga e sta seduto con gli amici in osteria”.
Il mattino prima di San Ilija io e Šilo, attraverso la finestrella del primo piano del casolare, osservavamo Maja che apriva con la chiave il lucchetto del baule magico. Tirava fuori qualcosa, spostava, parlava a bassa voce con se stessa. Io e Šilo non capivamo niente di quello che diceva e, per via del coperchio del baule, non riuscivamo a vedere niente. Maja poi comparve davanti a casa con una sporta di noci e della cioccolata. Io rinunciai volentieri alla cioccolata e la lasciai a Pavle e rimasi ad aspettare Papà per farmi schiacciare le noci.
Maja attraversò la strada, aprì il recinto dell’ovile e con la borsetta a tracolla fece uscire al pascolo il gregge di pecore. Soffiava il vento e le nuvole viaggiavano velocissime sopra le nostre teste. Già cominciava a tuonare quando Papà comparve presso il pozzo di acqua sorgiva. Come scoiattoli, io e Šilo scendemmo dal gelso e gli corremmo incontro per abbracciarlo. Papà mi prese e mi lanciò in alto, mi mise sulle spalle e tirò fuori dalla tasca una manciata di nocciole.
Risalimmo in fretta la strada polverosa fino al cortile, la macchia di ontani si piegava al vento, da lontano si sentivano i tuoni. Mentre Pavle chiudeva le finestre nella grande stanza, vedemmo sopra i tetti degli edifici e della casa i fulmini che squarciavano il cielo. Papà mi lasciò vicino al ricovero e corse incontro alla Mamma, tirando fuori dalla tasca una radiolina. Insieme raccolsero il bucato bagnato. Papà si precipitò in casa, uscì con l’ombrello in mano e sparì in un baleno dietro l’aia. Io rimasi per un po’ ad aspettarlo e poi mi addormentai con il rumore della pioggia e la melodia delle canzoni russe che usciva dalla nostra prima radio a transistor.
Quando mi svegliai il cielo era ancora scuro. La pioggia era cessata e qualcuno aveva steso di nuovo il bucato. Le galline di Pavle, Bianca e Rossa, zampettavano nel recinto creato da lenzuola e tovaglie stese, si venivano incontro, come per parlare. Poi passarono sotto lo steccato e si diressero verso Šilo e me che, dietro la distilleria, osservavamo tutta quella gente che risaliva la strada fangosa ed entrava nel nostro cortile.
Maja fu portata con il carro trainato dai buoi. La sua faccia era blu come la stoffa di lana che aveva sempre indossato in tutta la sua vita. Papà non piangeva. Soltanto tremava e guardava per terra.
Quel primo giorno di agosto, un fulmine uccise la nostra Maja. Mio padre la vide non appena uscì dal bosco di querce. Se ne stava tranquillamente ferma sotto l’albero con il suo gregge e aspettava che la tempesta passasse. E mentre Papà saliva il versante con l’ombrello in mano, cadde un fulmine così grande che quasi lo accecò. Subito dopo scoppiò il tuono. I pastori dicono che Maja rimase stecchita sul posto, mentre Papà, insieme all’ombrello, volò ancora a lungo per aria. Così svenuto rotolò giù per la collina. E rimase a terra lungo disteso.
Le piogge continuarono anche dopo il giorno di San Ilija. Gli alberi erano fradici e Pulcino, Šilo e io non potevamo stare seduti sul gelso. Lungo la strada fangosa si riversavano torrenti torbidi che sparivano nella buca sotto la macchia di ontani. Papà non prese mai più un ombrello in mano e anch’io da quell’estate non amo più gli ombrelli. Con lo sguardo cupo e la nuova ombra che per lungo tempo non lasciò il suo viso, si incamminò verso la 'Gommaria'. Al di là di Tikva, Mangura e delle altre nostre valli e montagne. Quando tornava, parlava poco. Di sera la casa era avvolta da un fitto silenzio, nessuno ascoltava la radio. Nonno Risto sedeva sul baule, dondolava le gambe corte e asciugava le lacrime con la manica. Papà sollevava lo sguardo dal piatto non toccato e si perdeva tra le volute di fumo della sua sigaretta. Pavle girava le pagine del libro di lettura preparandosi per il nuovo anno scolastico. Mamma si ritirò sotto la lampada a lavorare a maglia e da sotto le ciglia osservava come dalla bottiglia di vetro Mitar si versava un bicchierino di grappa dopo l’altro. Quando ci mettevamo a letto Papà digrignava a lungo i denti. E se pioveva e c’erano i lampi, prendeva a pugni la testiera di legno del letto con le sue grandi mani. Mamma allora accendeva la lampada sul comodino e bisbigliava qualcosa finché Papà non si calmava. Anch’io a quel punto mi addormentavo, non so se per il sussurrare della Mamma o per la pioggia.
Mentre raccoglievamo le prugne Šilo e io sentimmo Nonno Risto dire alla Mamma: “Babbucce sotto il braccio e via in città. Non c’è altra scelta”. Così capimmo che saremmo rimasti per qualche tempo con Nonno. Mamma preparò un pentolone di zuppa di carne e con Pavle andò in città. Il mattino seguente zio Lazar aiutò al Nonno Risto ad accendere l’alambicco e poi con la capra sparì dietro la montagna. Prima di partire Nonno gli disse: “E non tornate fino a quando non avrò distillato questa grappa. Se i mattoni costano, cuoceteli da voi. Io aprirò la fornace e voi estrarrete la pietra da Kocelj per la cantina. Porta a Raja e Mitar la capra e decidete insieme: o il latte o la carne”.
La zuppa era densa e grassa. Nonno stava zitto e piangeva davanti all’alambicco e sopra il piatto. Accendeva il fuoco nell’alambicco mentre la stufa continuava a rimanere fredda. E quando una mosca pigra dal bordo della pentola cadde nella zuppa non riscaldata e scomparve sotto il fitto strato di grasso, io e Šilo ci alzammo e andammo nella stanza grande. Là aprimmo il baule di Mamma dov’erano conservati i vestiti invernali, Šilo indossò il vecchio maglione di Pavle e io il mio nuovo maglione fatto a mano con i bottoni colorati. Per giorni rimanemmo seduti sul recinto in attesa che tutti tornassero. Io rigiravo i bottoncini del mio maglione e Šilo si mangiava le unghie, perché entrambi sentivamo che si avvicinava il giorno del nostro distacco. Allora il mio amico si voltò verso di me e, per la prima volta, mi chiamò con il mio soprannome: “Eh, Bottone mio, a che ci servono le grandi slitte che ci ha fatto lo zio Mitar, se te ne vai?” Io mi misi a ridere e dissi: “Tornerò, non ti preoccupare. Prima che il gelso fiorisca”. “E la slitta?”, ribadì Šilo.
Sotto la coperta, sul carro dei buoi si vedevano il letto di Mamma, il vecchio armadio, il tavolo ammaccato. Pavle accarezzava la gallina Bianca che sonnecchiava rannicchiata a un lato del rimorchio e con la testa sotto le penne. Nonno Risto chiuse il giogo attorno alla testa dei buoi e aspettò che ci salutassimo con Šilo. Mamma gli diede tre baci e scrollò la neve dal suo maglione di lana. Io stavo alcuni passi dietro di loro e tenevo in braccio Pulcino, che tremava tutto. Poi lo appoggiai nel carro e abbracciai Šilo. Mi diede i suoi guanti e, con un cenno della testa verso Pulcino, disse: “Lo abbiamo salvato dal colpo di sole. Fa’ che non muoia di freddo in quelle vostre montagne”. Nonno Risto aiutò Mamma a salire e a sistemarsi vicino a Pavle, colpì il bue sulla schiena e il carro partì lentamente in discesa. Appoggiato con i gomiti sul cancello, Šilo osservava in silenzio le tracce bianche delle ruote sulla neve. Gallina Rossa faceva coccodè, agitava le ali e tirava lo spago con cui era stata legata alla maniglia di metallo del baule. A me era venuto il torcicollo a furia di girarmi indietro, poi mi alzai e saltai giù dal carro. Pulcino corse dietro di me fino al cancello, dove lo presi in braccio e lo diedi a Šilo. Mamma fermò i buoi vicino al pozzo di acqua sorgiva e mi aspettò.
La tempesta di neve diventava sempre più forte, davanti a noi si era formato un muro bianco. I buoi continuavano a tirare il nostro carro e la mamma teneva strette le redini di cuoio ghiacciato. Non mi girai più indietro ma sapevo che Šilo era là sulla staccionata del recinto e che ci sarebbe rimasto fino a quando non saremmo spariti dietro la curva.
Era già buio quando arrivammo e così non vidi che il pezzetto di terra su cui Papà aveva deciso di costruire la casa era su una nuda pianura. Sulla montagna innevata regnava un vento gelido. La casetta di legno di Nonno poggiava su quattro pietre. Mamma aprì la porta, appoggiò le borse, passò accanto al secchio con l’acqua ghiacciata e accese la lampada. Io mi tolsi i guanti nuovi e slegai lo spago dalle zampe delle galline. Nell’altra stanza si sentiva belare la capra. Tutte e due le galline facevano coccodè, attraversarono di corsa la stanza, s’infilarono sotto la costruzione e sparirono nella bufera. Mamma si avvicinò al letto di ferro, sollevò la coperta sotto cui dormiva rannicchiato Papà, fece un gesto di disapprovazione con la mano e uscì fuori. Io saltai felice sul letto per abbracciarlo. Assonnato alzò la coperta e con la sua grande mano mi trasse a sé. “Ehi, Bottoncino, ma sei tutta infreddolita. Stenditi qui al calduccio e non muoverti. Arrivo subito”. Quindi calzò i pesanti zoccoli, mi accarezzò i capelli, tolse dal chiodo il cappotto e lo gettò sopra la coperta. Il cappotto aveva il profumo di Papà e il letto quello della grappa. Il vento sibilava, trasportava la neve sotto la nostra casetta provvisoria, la sbatteva sugli angoli. Mamma e Pavle portavano dentro i mobili e Papà andò ad aiutarli. Mamma sommessamente borbottò: “Mitar, dove è finita la tua anima?”
Papà chiuse l’armadio e Mamma si mise a sedere davanti alla stufa per accendere il fuoco. Pavle era disteso nel letto accanto a me e tremava come una foglia, finché non si addormentò. Al buio mi sentivo soffocare dalla coperta e a un certo punto la sollevai un po’. Il vento si calmò e nella camera ardeva la lampada a petrolio. Il fuoco sfrigolava e la neve pian piano scompariva dal pavimento di terra, portandosi dietro le impronte delle galline. Dal secchio si sentiva il rumore sordo del ghiaccio che si scioglieva.
Con la voce roca, dal profondo della stanza, Papà disse: “Vieni a sederti accanto a me”. Io mi coprii fin sopra la testa con il suo cappotto e mi strinsi vicino a Pavle. Dopo un breve silenzio si udirono dei passi, poi le molle del letto e la voce della Mamma: “Tu vuoi farmi diventare vedova e lasciarmi da sola con due bambini così piccoli, vero, Mitar?”
Quella notte mi addormentai felice perché eravamo di nuovo insieme. Sognai che mi trasformavo in un bottone e che Papà mi portava sempre con sé nel taschino interno del suo cappotto.
Abitavamo nel nuovo quartiere operaio, in tutto alcune case sul monte. Dopo la morte di Maja Papà cominciò ad avere paura del buio e nella nostra casa era sempre accesa la luce. Capitava che di sera, appena chiudeva gli occhi, dall’altra stanza arrivasse il belato della capra. Mamma saltava giù dal letto e prendeva la lampada. Prima di varcare la soglia si girava e diceva: “Dormite, bambini, anche la capra ha paura del buio”. Sotto la coperta Pavle stringeva i pugni e bisbigliava: “Si vendica perché l’abbiamo portata via dalla campagna. Ha paura solo di Papà”. Io rispondevo: “E del buio. Soffre di insonnia. Come Papà”. Papà sopportava la capra perché era l’unica nostra ricchezza. E lei si lasciava mungere solo in sua presenza. Quando di mattina Papà si alzava, dopo una notte insonne, ed entrava nell’altra stanza per prepararsi per il lavoro, Mamma entrava silenziosamente dopo di lui e accendeva la radio. Al suono della musica la capra si alzava e aspettava che Mamma la mungesse. La casa profumava di uova fresche e di latte, Pavle dormiva mentre Papà si insaponava e radeva in compagnia dell’immagine della capra sullo specchio. Poi lucidava le scarpe e, aiutato dalla Mamma, indossava il cappotto appena spazzolato. “Sei bello come un attore”, gli diceva prima di accompagnarci al cancello.
In silenzio passavamo davanti alle povere case fino in fondo alla via e attraversavamo la strada. La capra pascolava sulla collina vicina mentre Papà scendeva lungo la strada che, un tornante dopo l’altro, conduceva fino allo stadio. All’incrocio, la luce smorzata fissava e accompagnava gli ultimi clienti dell’osteria. Dall’altra parte della strada, vicino al monumento dei combattenti caduti per la patria e la libertà, c’era un autobus con i fari accesi. Quando si chiudevano le porte dietro la schiena dell’ultimo operaio della fabbrica di gomma, l’autobus scendeva a valle mentre io, con la capra, scendevo verso la macchia di noccioli. Lo seguivo con lo sguardo finché non si perdeva nel buio. Si vedevano soltanto la cittadina assonnata nella conca e le viuzze che si arrampicavano sul monte come fagiolini su una pertica. La capra brucava e lentamente mi seguiva.
Nei giorni in cui Papà dopo la 'Gommaria' non faceva tappa in osteria, Mamma lo aspettava felice e con il pranzo in tavola. “Io ho mangiato con i bambini”, mentiva e usciva in fretta per preparare la carriola, il piccone e le funi metalliche per andare alla cava di Kocelj. Papà tirava fuori dalla tasca del cappotto una scatoletta di carne della mensa della fabbrica e la metteva sul tavolo. A me non piaceva quella carne perché mi ricordava la zuppa grassa che io e Šilo avevamo mangiato, fredda, con Nonno Risto. Prima che facesse buio Pavle puliva il pavimento e accendeva il fuoco. Quando la capra belava, accendeva la lampada e la portava nell’altra stanza. Dalla fontana portavamo insieme il secchio dell’acqua, una parte la versavamo nel catino e la facevamo scaldare sulla stufa. Mamma e Papà tornavano tardi, sporchi di polvere e stanchi morti dopo il lavoro nella cava. Entravano in casa, deponevano gli attrezzi nell’angolo, Pavle preparava la tinozza con l’acqua per il bagno per Papà, mentre Mamma riscaldava in padella i pezzi di pita.
Colonne di camion passavano accanto al nostro quartiere fin dal mattino presto. Salivano, in una nuvola di polvere, lungo i tornanti della strada che veniva dallo stadio e sparivano dietro ai boschi di conifere, dove stavano costruendo il nuovo hotel di montagna. La sabbia sottile e la ghiaia scivolavano dai lati dei rimorchi e lasciava tracce lungo la strada tortuosa. Mamma tirava su ghiaia e sabbia con la scopa e la paletta, con pazienza e tenacia, giorno dopo giorno. Le raccoglieva in mucchietti sperando che prima dell’inverno potessero servire per intonacare la nuova casa. Di mattina, nella carriola vuota, accanto alla scopa e alla pala metteva anche la cartella di Pavle. Uscivano insieme in strada e camminavano uno accanto all’altra fino in cima al quartiere dei rom musulmani. Pavle l’abbracciava e, presa la ripida scorciatoia, correva verso la scuola. Lei rimaneva per un po’ a osservarlo. Poi raccoglieva i capelli sotto il fazzoletto, si chinava e cominciava con la scopa a raccogliere in mucchietti la sabbia e la ghiaia scivolate dal camion. Aspettando Papà talvolta scendeva con la scopa o la spazzola in mano fino all’ultima curva sopra lo stadio. Quando capiva che non valeva la pena di aspettarlo, ritornava tutta sudata e rovesciava la carriola piena di sabbia nel cortile. In silenzio si lavava, indossava la giacca logora di Papà, mi faceva le trecce e diceva: “Andiamo a prendere Pavle”.
I cortili delle case musulmane erano senza recinto e cancello e in tutti c’era almeno un albero. Le case avevano i tetti di lamiera e le grondaie, i cortili erano puliti e in ordine. Le donne più anziane se ne stavano davanti alla soglia, fumavano e invitavano Mamma a bere il caffè. Le donne giovani, sempre affaccendate, preparavano la marmellata, strofinavano i tappetini sottili di lana e i tappeti kilim. Con i catini pieni di bolle di sapone passavano accanto a noi e a bassa voce dicevano: “Buona sera, vicina!”.
I ruscelli formati dall’acqua dei catini rovesciati scorrevano sulla via ripida e sparivano nella voragine dietro i susini e i glicini. Io li guardavo e mi ricordavo le piogge del giorno di San Ilija che avevano portato via per sempre la nostra Maja. Mamma mi tirava per la manica e mi diceva: “Attenta a dove metti i piedi. Le bolle di sapone racchiudono i segreti degli altri”. Sulla strada di ritorno Pavle si accorse di come guardavo incantata gli ampi pantaloni fruscianti stretti intorno alle caviglie delle donne musulmane e mi spiegò che una volta la cittadina in cui ci eravamo trasferiti era sotto il dominio turco. Quando chiesi: “Quanto tempo fa?”, Mamma dopo averci riflettuto un po’ disse: “Tanto tempo fa, figlia, quando Nonno Risto era ancora piccolo”.
In cima alla via incontrammo il sordomuto Mujko e Redžo che erano tornati carichi dal bosco. Mujko tirò fuori dalla borsa un pugno di bacche di rosa canina e lo diede a Mamma. Redžo depose a terra il pesante fardello di legna e affannato disse: “Eh, vicina mia, Mujko conosce la montagna meglio dei guardaboschi. Potrebbe mettere il manico a tutte le asce di questa maledetta città”. Mujko si girò e felice mostrò i manici che portava sulla sua lunga schiena. Mamma rise e disse: “E tu, Redžo, potresti cuocere i mattoni e costruire tutti i nostri comignoli”. Redžo prese a scendere, strizzò l’occhio a Pavle e tossendo aggiunse: “Magari avessi anch’io i buoi e i cavalli come tuo nonno. Ma nel bosco, Redžo, è da solo che devi portare i pesi. Finché ti regge la benedetta schiena”.
Era il primo giorno del mese e gli operai della 'Gommaria' avevano ricevuto la paga. Scendeva già il buio e di Papà non c’era traccia. Davanti all’icona di San Nicola Mamma accese una candela e mormorò: “Dio, aiutaci, ti prego. Madre di Dio, San Nicola, tutti i santi e angeli tutti, vi prego. Proteggete i miei bambini e aiutateci”. Dopo la preghiera andammo verso la macchia di noccioli per prendere la capra. I camion sgombri del carico scendevano dalla montagna a gran velocità. Le catene tintinnavano, balzavano e sbattevano rumorosamente sui lati vuoti dei rimorchi. La capra si era impuntata sul ciglio della strada e non c’era verso di smuoverla da lì. Pavle le torse l’orecchio e disse: “La tua sfacciataggine supera di gran lunga il tuo peso”. Mamma stringeva forte la corda temendo che Bela, così avevamo chiamato la capra, si liberasse e finisse sotto le ruote dei camion. Avvertendo su di sé il mio sguardo, Mamma si voltò e disse: “Vai, figliola”. Loro tre rimasero nella grande nuvola di polvere, io feci di corsa la strada fino allo stadio.
C’era da vergognarsi a entrare in osteria. Per ore rimasi ferma lì davanti dall’altra parte della strada, nella speranza che Papà si girasse e mi notasse. Lui era allegro, brindava con i compagni, offriva da bere. Redžo fu il primo a uscire dall’osteria. Quando mi vide, chinò la testa, tornò indietro e sussurrò qualcosa all’orecchio di Papà. Lui fermò la musica, prese il cappotto sotto braccio, si avvicinò al banco, pagò il conto e usci in più in fretta che poteva.
Camminavamo in silenzio lungo la strada. Papà trascinava dietro di sé i pesanti zoccoli e digrignava i denti. La notte era fredda e la luna taceva dietro le nuvole scure. Le prime gocce di pioggia ci raggiunsero al portone. Grosse e pesanti, cadevano sull’argilla secca e in fretta sparivano nelle crepe del suolo. Ogni volta che si vedeva un fulmine e illuminava la casa, dall’altra stanza Bela belava. “Forse crede che stia facendo giorno”, dissi a Pavle ridendo. Lui mi girò le spalle e continuò a leggere come se non mi avesse sentita. Mamma in silenzio appoggiava la cena sulla tavola. Invece del vaso con i fiori, mise sul tavolo un piedistallo con una bandierina rossa e con orgoglio disse: “Pavle è il più bravo della classe. Diventerà un dottore”. Papà prese dalla credenza due bicchierini di grappa e disse: “Siediti, Raja, che parliamo un po’. Anch’io sono membro del partito comunista e sono il migliore operaio della ‘Gommaria’. E a cosa mi serve? Finora ho mangiato più fuliggine che pane”. Dalla tasca del cappotto tirò fuori una bottiglietta di grappa, la versò in una fila di bicchierini, guardò attorno a sé e disse: “Guarda come viviamo. La miseria è rimasta miseria”. Pallido come un cencio, Pavle chiuse il libro e uscì fuori al buio. Mamma prese l’asciugamano e disse: “Dai, Mitar, lavati che andiamo a dormire. È tardi. Parleremo domani”. Papà tirò la tovaglia e tutta la cena cadde dal tavolo. Senza dire niente prese il catino con l’acqua bollente della stufa e la versò per terra. Come se non fosse successo niente, Mamma fece un cenno con la mano e uscì fuori.
Dal letto di ferro seguivo le mani di Papà. Riempivano e portavano alla bocca uno dopo l’altro i bicchierini di grappa. Fuori tuonava e Bela non faceva altro che belare. “Non è una capra ma un diavolo”, gridò e scolò giù d’un fiato due bicchierini. Non so quanto tempo trascorse prima che Pavle comparisse sulla porta bagnato fradicio. Tremando e battendo i denti, passò accanto al tavolo, si fermò vicino al letto e cominciò a spogliarsi. Papà con la voce ubriaca biascicò: “Studia tu, da bravo. Come se potessi cambiare qualcosa”. Pavle si infilò sotto la coperta e senza alzare lo sguardo disse: “Sei ruggine, Mitar”. In due passi Papà comparve all’improvviso accanto al letto. Afferrò Pavle per la canottiera e lo gettò in fondo alla stanza. Lo colpiva con i pesanti zoccoli e non si era neanche accorto che Pavle era caduto oltre il secchio dell’acqua, aveva perso il respiro sbattendo contro il manico del secchio rigido ed era svenuto. Mamma corse in casa, soffiò nello stoppino e si fermò in mezzo a loro. “Se tua madre fosse viva che cosa ti direbbe?” riuscì a dire prima che i colpi sordi e il trambusto riempissero la stanza. Allora saltai anch’io e afferrai le ginocchia di Papà con entrambe le braccia.
Mamma e Pavle quella notte non dormirono in casa. Papà si trascinò carponi fino al tavolo e rimase seduto tutta la notte. Accesi il fuoco nella speranza che gli venisse sonno e si addormentasse. Quando finì di bere tutta la grappa, si afferrò la testa con le mani e disse: “Eh, Bottone mio, che vita di merda”. Poi mise in bocca il bicchierino di vetro e lo spezzò con i denti.
Alla 'Gommaria' andò senza fare colazione prima dell’alba e quel giorno non rincasò.
Pavle passò a letto tutto il giorno con la febbre alta. Tossiva senza sosta. Mamma si prendeva cura di lui, sudava, gli preparava impacchi di patate e farina di mais. Quando Pavle si calmò un po’ e si addormentò, Bela cominciò a belare, come se presagisse qualcosa di brutto. Di sera la febbre salì e Pavle prese anche a delirare. Mamma mise nella borsa il prosciutto che ci aveva mandato Nonno Risto e mormorò: “Non è per chi è stato pensato, ma per chi è destinato”. Avvolse Pavle nella coperta e lo portò da Vezira, la moglie di Mujko. Ad aprirci la porta venne la figlia Fata e disse: “Entrate”. Mamma passò con Pavle nella stanza in cui c’era Vezira ad aspettarli, mentre io ero così accecata dalla bellezza di Fata che non riuscivo a muovermi dalla soglia. Aveva la statura del padre, le gambe lunghe, la vita sottile. Percorreva lo stretto corridoio facendo ondeggiare i capelli neri che mi fecero venire in mente la criniera del morello di Papà. In cucina tirai fuori dalla borsa il prosciutto del nonno e lo appoggiai sul tavolo. Sulla piastra della cucina economica in un grande pentolone bollivano le pelli di pecora. Attraverso la porta socchiusa si vedeva una grande stanza piena di gente sconosciuta che stava in ginocchio sul tappeto e si inchinava. Fata versò il caffè nelle tazzine, guardò la grande spalla di prosciutto e disse: “Non serve a nulla. Vezira mangia come un uccellino. Ma fuma come un turco. Riprenditi il prosciutto e domani va’ a comprare delle sigarette e portale qui”.
Vezira stette a lungo a fare giochi di prestigio mentre io e Fata sedevamo sulla panca e aspettavamo. Chiusi gli occhi e pregai Dio che tutto tornasse come prima, che Pavle guarisse e che, arrivati a casa, trovassimo ad aspettarci Papà, sobrio.
Pavle si rimise in fretta. Mamma gli preparava tisane di malva, gli faceva massaggi e impacchi con le erbe di Vezira. Vezira venne da noi a fargli visita. In modo quasi impercettibile bussò alla porta, entrò e si sedette sul tappeto. Con le gambe incrociate bevve il caffè, capovolse la tazza e aspettando che i fondi scendessero fumò mezzo pacchetto di sigarette. Leggera come una piuma volò fuori in strada prima che Mamma tirasse fuori dalla tasca del corpetto cinque dinari e mi dicesse: “Va’ a comprare le sigarette”. Girai per tutte le bettole della cittadina chiedendo di mio padre. Allo stadio un uomo mi disse: “Be’ ieri è andato alla ‘Gommaria’ direttamente dall’osteria”. Presi l’autobus della fabbrica e andai a cercarlo al lavoro.
Papà era disteso nell’infermeria della fabbrica, con la faccia nera e le occhiaie. “Ho lavorato tutto il giorno e poi di sera mi è venuta la febbre. Da ogni parte arrivava corrente d’aria, allora sul nastro mi sono fatto una grande calda coperta di gomma, mi ci sono avvolto e mi sono disteso sotto il banco per riposare un po’. Quando mi sono svegliato, non riuscivo più a parlare e a respirare”. Nella stanza entrò il dottore e disse: “Per fortuna che sono arrivati gli operai del terzo turno. L’hanno trovato livido e mezzo morto. Qualcuno ha tagliato la gomma fredda e ha chiamato il mio collega”. Mi accostai alla finestra. Nell’edificio circolare della fabbrica, vicino alle fuligginose finestre rotte, neri come corvi, c’erano gli operai in piedi che fumavano. “Perché qui è tutto così nero, Papà?” domandai. Lui si sollevò dal letto, tossì e disse: “Di fuliggine e di residui, Bottone. Alla fine del turno anche i peli delle narici diventano neri”. “Per questo motivo fai il bagno ogni giorno?” Lui mi fece una carezza sulla testa, si inumidì le labbra secche e disse: “Nella nuova casa avremo anche noi un bagno con la vasca. Così potremo lavarci tutte le volte che vorremo”.
Papà promise a Mamma di non bere più. Si assentò dal lavoro per malattia e si decise a fare il tetto per la casa. Pavle appese un piccolo calendario accanto al letto e cerchiava i giorni sobri di Papà. Una mattina scese presto in città e tornò con un camion pieno di tegole. Saltò giù, aprì lo sportello del rimorchio e guardò con gioia in direzione di Mamma. Dalle tasche dei pantaloni gli caddero delle banane di cioccolata. Pavle osservava il mignolo della mano di Papà che si muoveva, e sottovoce disse a Mamma: “Sembra brillo”. Papà gli fece cenno con il dito di avvicinarsi, poi si mise a ridere e tirò fuori da sotto il maglione un atlante geografico. Nonno Risto entrò giusto in quel momento in cortile con un montone e con un fiasco di grappa sotto il braccio. “Che Dio ti aiuti, padrone!” “Che Dio aiuti te”, rispose allegramente Papà. Strappai l’atlante dalle mani di Pavle e corsi verso il portone. “Papà, quando mostreremo l’atlante a Šilo?” Lui mi fece salire sulle sue spalle e rispose: “Presto, Bottoncino, appena Pavle finirà la scuola”. Nonno aggiunse: “Giusto quando matureranno le more del gelso. Vi aspetto per falciare i prati”.
I vicini di casa vennero senza essere stati chiamati, si misero in colonna e in un batter d’occhio scaricarono il camion. Mujko rimase sul tetto fino a notte legando pazientemente le tegole con la corda. Redžo scuoiò abilmente il montone del Nonno e lo arrostì allo spiedo. Vezira portò la teglia con la pita e un grande pentolone nero di fuliggine. Si rimboccò le maniche, mise in un catino le viscere e le budella della pecora, e le portò con Mamma alla fontana. Quando tornarono, Mamma tagliò tutto a pezzetti mentre Vezira in fondo al cortile accese il fuoco sotto il pentolone e sciolse il grasso.
Pavle trascorse la giornata sotto l’albero di prugne, guardando l’atlante e mangiando le banane di cioccolato. Io invece saltavo intorno a lui e lo pregavo di mostrarmi sulla mappa la nostra casa di campagna e la cittadina di montagna in cui ci eravamo trasferiti. Lui mi diede un colpo secco con le dita e, con la bocca piena, disse: “Negli atlanti non ci sono distanze così brevi. Con l’autobus arrivi in campagna nel tempo di uno sputo”.
Di sera tutti cenarono insieme davanti alla casa nuova, il fiasco di grappa del nonno stava per finire, qualcuno portò la fisarmonica. Mamma e Vezira bevevano il caffè vicino al pentolone con le frattaglie cotte. Vezira prese in mano la tazza rovesciata di Mamma e, accanto al fuoco, le diceva piano qualcosa. Raja si fece il segno della croce e disse: “Grazie a Dio misericordioso, finalmente non mi pioverà più sulla testa. Per il resto – sia fatta la sua volontà.”.
Gli ospiti lentamente se ne andavano, l’ultimo fu Redžo, con la pelle di pecora e le corna nel sacco. Papà bevve abbastanza, ma era allegro. Dopo avere accompagnato tutti, si avvicinò al tavolo dove Pavle stava seduto da solo e chiese: “Cosa vuoi che ti compri Papà per essere stato promosso?” Senza sollevare la testa Pavle rispose: “Una fisarmonica”.
Mamma spruzzava l’acqua sulla terra battuta e con la scopa puliva il pavimento della nuova casa. Di tanto in tanto si girava per guardare indietro. Contenta apriva le braccia e girava su se stessa. Papà entrò nella cucina al piano terra della futura casa, portandosi dietro la capra e disse: “Domani pagherò le tegole e i lavori di falegnameria. Mujko ha comprato la nostra casetta di legno”.
Mamma preparò le frittelle e la borsa per la campagna, Papà si rasò la barba e lucidò le scarpe nere. Era giorno di mercato e le strade della cittadina pullulavano di gente. La fisarmonica era rossa e splendeva ancora di più sotto il sole di fine giugno. Pavle camminava lentamente portando sulla schiena il suo desiderio realizzato. Ogni tanto si fermava per guardare la propria immagine riflessa sulla vetrina di qualche negozio. Papà portò la custodia vuota fino alla stazione degli autobus. Aprì la porta della bottega di čevapčići e gridò: “Due panini con i čevapčići”. Si avvicinò al banco, appoggiò a terra la custodia e a bassa voce aggiunse: “e un bicchierino di quella gialla”.
L’autobus per il villaggio tardava e Papà svuotava un bicchierino dopo l’altro. Quando dal portafogli tirò fuori e appoggiò sul banco due banconote rosse, Pavle si rabbuiò, lasciò i čevapčići sul tavolo, si caricò la fisarmonica sulla schiena e mi disse: “Io vado a casa”. Papà quel giorno offrì da bere a tutta l’osteria. Verso sera gli andai vicino e dissi: “A me non hai comprato niente per la promozione di Pavle”. Allora lui salutò tutti e, con gli ultimi soldi, comprò la mia prima salopette.
Quando arrivammo in campagna era già notte. Papà lasciò la borsa vicino al cancello aperto. Attraversò la strada e guardò a lungo l’aia non falciata e il recinto vuoto. Dalla stalla uscì il suo morello: camminava lentamente e a testa china. Sull’aia si fermò e diede un colpo di zoccolo sulla terra. Il cancello del recinto cigolò un po’. Entrai nel cortile e mi misi a sedere sulla panca. Il ricovero era vuoto e il gelso taceva. Sul sentiero bagnato giacevano i frutti che nessuno aveva raccolto. Papà si avvicinò al ricovero e rovesciò il boccale con l’acqua. Poi si sedette vicino a me, appoggiò la testa al fusto dell’albero e ne osservò a lungo le fronde. Le galline stavano accovacciate sulla traversa del pollaio e le loro penne non luccicavano.
In casa regnava un insolito silenzio. I letti erano vuoti, i materassi arrotolati. Nonno Risto dormiva e il nostro Mitar ci preparò i letti senza accendere la luce. Si rigirò nel letto a lungo. Infine accese la lampada, si mise le scarpe e, pensando che dormissi, uscì fuori silenziosamente.
Pulcino, Šilo e io sedevamo in cima al gelso fin dal mattino presto. Šilo aveva imparato a suonare il flauto e Pulcino ad aprire le ali a ritmo della musica. Non appena nonno Risto, con la falce in spalla, si allontanò per andare a Potok, noi tre scendemmo dall’albero. Correvamo e saltavamo per il cortile. Šilo ripeteva: “Lee Cooper, Lee Cooper” cercando di afferrarmi per le bretelle della nuova salopette. Papà fumava sulla panca davanti al granaio come se non si accorgesse di noi. Ogni tanto sollevava la testa e guardava oltre l’aia. Poi si spostò sotto il gelso e vi rimase fino all’ora di pranzo, versandosi un bicchierino di grappa dopo l’altro. Soltanto quando le galline salirono per le scale e si sedettero davanti alla porta socchiusa del casolare, si alzò e sparì nel buio della cucina.
Pulcino, Šilo e io ci riparammo all’ombra del frutteto più lontano. Mangiavamo le amarene e osservavamo la scrofa di Nonno che riposava sotto l’albero. Šilo disse: “Penso che dovremmo svegliarla un po’. Salta tu per prima, afferrala per le orecchie e tieniti forte a lei”. Io lo guardai stupita e chiesi: “E tu?” “Io salterò subito dopo di te”. Alla fine saltammo giù insieme. Anche la scrofa saltava come se si fosse scottata con l’acqua bollente. Si dimenava, strillava e cercava di buttarci giù dalla sua groppa. Io la tenevo forte per le orecchie e morivo dalle risate. Non ebbi paura neanche quando la scrofa furiosa cercò di prendermi il piede con il muso. Šilo la teneva per la coda, saltava su e giù e gridava: “Strilla come se qualcuno la stesse scannando”. La scrofa scese di corsa passando davanti alla distilleria, al caseificio e agli altri edifici. Svoltò dietro l’angolo della casa. Conficcò le unghie nel terreno e inchiodò. Nonno Risto rimase impalato davanti al cancello. Papà girava le stazioni sulla radio in cucina e non ci sentiva. L’ultima cosa che ricordo è la musica della canzone partigiana “Avanti popolo, avanti… la stella rossa… la trionferà, la stella rossa la trionferà… evviva il comunismo e la libertà…” Non vedevo Šilo, ma solo una nuvola di polvere e tantissime stelline sopra la testa. Papà poi raccontò che eravamo volati come due palloni pieni d’aria, che avevamo più fortuna che sale in zucca perché la scrofa avrebbe potuto farci a pezzetti. Nonno girava la testa in segno di disapprovazione e disse: “Mamma mia, canaglie che non siete altro! Potevate infilzarvi sulla staccionata. E Dio non vi avrebbe rimesso a posto.” Nonno Risto cacciò a casa Šilo e Pulcino. Io, a testa bassa, entrai in cucina, passai accanto al focolare spento e mi misi seduta a tavola. Continuava a girarmi la testa e mi bruciavano le ginocchia sbucciate. Da sotto la tovaglia cerata spuntarono due buchi sui jeans.
Nonno Risto chiuse le finestre e guardando fuori disse: “Come scotta il sole, è tutto bruciato. L’erba è secca come polvere da sparo. Dobbiamo falciare a Osoje”. Sulla corda del bucato, in cortile, si era appoggiato un merlo. Come se avesse avvertito lo sguardo di Nonno, si girò verso la finestra. Papà senza dire alcuna parola mise i piatti in tavola, versò la zuppa, un bicchiere di grappa e si sedette.
“Che hai?” domandò Nonno a Papà. “Pioverà. Mi fa male ’sta maledetta testa, mi sembra d’impazzire” rispose il mio Mitar. Io sminuzzavo il pane nel piatto e guardavo la foglia secca, volata da chissà dove, che si era attaccata al vetro della nostra finestra. Nonno borbottò: “Anche questo si chiamerà ieri” e continuò a masticare lentamente.
La punta della falce sulla spalla di Papà brillava come una lucciola nel buio. Camminavamo lungo il vecchio sentiero in silenzio. Dall’argilla battuta si alzava molta polvere che si attaccava alla pelle dei nostri piedi nudi e alle gambe. Insieme togliemmo un arbusto di biancospino e ci addentrammo nell’erba alta di Osoje. Era fresca e umida. Arrivammo fino alla vecchia quercia. Papà attaccò a un pezzo di ramo la borsa con la colazione, si rimboccò le maniche della camicia e disse: “Fintanto che l’erba è bagnata e i serpenti dormono, vai a prendere l’acqua a Potok. E attenta a dove metti i piedi”.
Sotto la fale implacabile i fili d’erba volavano e cadevano disponendosi come pieghe lungo il lato ripido. La campagna si svegliava pian piano e le colline del podere di nonno mutavano con un gioco di luci accecanti e di ombre taglienti proprie dell’estate. Con i gomiti sull’erba Papà faceva colazione con pita di spinaci e yogurt acido. La rugiada dagli alberi spariva lentamente e preannunciava una caldissima giornata estiva. Le ombre regnavano ancora nel cortile quando Nonno Risto uscì di casa e mandò fuori gli animali dalla stalla. Questi passarono accanto al recinto vuoto e sparirono dietro la collina.
“Bottone!!!” gridò Papà e corse in direzione della quercia dove stava appesa la falce. Feci un balzo e, mentre saltavo, scorsi il corpo a forma di ferro di cavallo di un serpente velenoso scuro che usciva dalla sua tana buia. Poi, con un suono sordo come quello di quando il tappo esce dalla bottiglia, sbucò fuori dalla terra la testa. Sotto il piede nudo avevo sentito il suo corpo freddo e viscido. Corsi con tutte le forze, a più non posso. Con la falce alzata e lo sguardo atterrito Papà mi raggiunse di corsa.
Le giornate in cui è impossibile trovare ombra mi ricordano gli addii. E il palmo sudato della mano di Papà che mi conduce per il sentiero deserto di campagna. Camminavamo lungo il recinto di rami di biancospino seccato dal sole. La pesante borsa da viaggio, strusciava sui pantaloni di Papà in modo appena percettibile. Nella calura estiva, senza un filo di vento, ci accompagnavano gli arbusti di biancospino secco. Papà a un tratto si fermò e si voltò verso la muta abbandonata del serpente velenoso che pendeva da un cespuglio scuro lungo la strada. Io e Papà non ci incontrammo più.
Nella ghiacciata città di sabbia i bricchi di rame tremano dal freddo. Raggomitolati sui caldi tombini, i gatti non fanno caso al vento. I bambini dell’Oriente che non hanno mai visto prima un pupazzo di neve giocano a tirarsi palle di neve. I vecchi accostano le guance al vetro della finestra ricoperto di brina e guardano spaventati i lampioni piegati dalla tormenta. Il fico accanto alla torre di pietra si è gelato. L’imano ricorda alle rare figure bianche e nere in movimento che è giunta l’ora del riposo e della preghiera. La moschea è l’unico posto nella città vecchia dove le porte rimangono ancora aperte. I caravanserragli hanno sprangato le imposte, nelle sale da tè e da caffè le cucine sono chiuse, il furgoncino del pane è rimasto in fondo alla scarpata, senza le gomme invernali non ce l’ha fatta ad arrampicarsi. I tappeti hanno avvolto i ricordi e sono rimasti ad aspettare negli spazi dei negozi chiusi, la bandiera che sventolava sul molo ricordava la patria e i giorni da pioniera con il fazzoletto rosso intorno al collo.
Quella notte nei miei sogni navigava una nave immensa. Sul ponte: Raja, Maja, un amico sconosciuto e io. L’ascensore della nave sembra quello di un hotel, da anni nella città di sabbia lo uso per andare fino all’ultimo piano. Raja mi invita a entrare, prima di arrivare in porto desidera che facciamo il bagno in piscina tutti insieme, nelle profondità della nave. “L’acqua è pulitissima, sembra il mare aperto”. Prima di lasciare il ponte vedo il golfo verde, le colline, lo stadio, l’autobus della fabbrica, il monumento, l’osteria, la via abitata dagli zingari, il villaggio, il tetto rosso della nostra casa. Tutto è cristallino, a portata di mano, come l’acqua verde tagliata dalla prua della nave. Le palpebre mi si chiudono. Aspettando che Raja e Maja escano dall’ascensore guardo il mosaico della piscina, sforzandomi con tutta me stessa di non stendermi e di non sprofondare nel sonno. Alla fine cedo. Mentre dormo su un pavimento piacevolmente fresco, sento risuonare, nel vasto spazio della piscina, le risa della mia Raja. Sento la bocca aprirsi contro la mia volontà. E dalle viscere uscire qualcosa di grande, scuro e viscido. Dal mio corpo esce con impeto una massa densa, come il fumo dal camino della 'Gommaria'. Lo sforzo di aprire gli occhi è inutile. Vorrei urlare, vorrei svegliarmi. Ma non ci riesco. Alla fine sento il grido della mia Raja. Mi sveglio nel sogno. La piscina è vuota. Sul fondo asciutto il corpo dell’enorme serpente velenoso che mi ha lasciato, la mia Raja lo taglia a metà con una spada. Intorno a me il silenzio. Ma solo per un attimo.
Fuori fischia il vento. Le finestre sono ghiacciate. I tubi di scarico del bagno dell’hotel puzzano, il telefono è staccato. Scendo giù per le scale, manca la corrente, il ragazzo della reception dorme. Sulla stretta strada ghiacciata i rari passanti si muovono con cautela. Vedo Mitar giovane che cammina sulla neve non calpestata del nostro villaggio oltre i monti e le vallate fino alla città. Con il cappotto sbottonato e la bottiglia di grappa nella tasca interna. Vedo anche il bicchierino che lui spezza con i denti prima di sputare il vetro frantumato e il sangue sul manto di neve intatto. Sento i passi mentre cammina accanto al lago ghiacciato con tre barche abbandonate. Si gira, ride: “Buon compleanno, Bottone”.
Mentre cammino mi appoggio alle saracinesche dei negozi chiusi, mi afferro ai lucchetti ghiacciati di portoni sconosciuti. In un piccolo negozio soffocante trovo un barattolo di cetrioli sott’aceto, formaggio, whisky. Un pranzo modesto per un giorno di festa. Si accende la luce, inizia a vibrare il motore del frigorifero.
Indosso il vestito rosso. Nel tegame si cucinano le cosce di pollo. Aspetto che qualcuno chiami. All’improvviso si apre la porta del balcone e un ragazzino con un fascio di giornali entra nella stanza. Torna indietro, solleva un vaso rotto di gerani ghiacciati, riempie il barattolo di neve e in un fascio di giornali mi porge un mazzo di crisantemi bianchi: “Auguri!” Quel mattino presto di primavera il Mar Caspio si svegliò congelato. Era il giorno del mio compleanno.
Sulla panchina del corridoio dell’ospedale, prima dell’alba, quello stesso giorno il mio Mitar è morto. Pavle si rimboccò le maniche del maglione nero e scolando un bicchiere di grappa dopo l’altro, disse: “Gli ho detto in faccia tutto quello che mi ero tenuto dentro per tutta la vita. Nella diagnosi sta scritto che è morto di polmonite. Chi è oggi che muore di polmonite, dimmi tu!”
FINE
Si tratta della tipica casa serba con struttura e tetto in legno. Facilmente smontabile e adattabile ad ogni necessità, modulare. In campagna spesso viene adagiata su un cumulo di sassi o pietre, soprattutto se è costruita per essere utilizzata durante il periodo estivo. Se deve essere abitata, lo scheletro in legno viene fissato alle fondamenta in pietra.